di Ilan Pappe
Information Clearing House, 12 giugno 2018
dal libro Ten Myths About Israel, uscito per Verso Books.
Israele non è l’unica democrazia nel Medio Oriente. Anzi, non è affatto una democrazia.
Agli occhi di molti Israeliani e dei loro sostenitori nel mondo – inclusi coloro che criticano alcune delle sue politiche – Israele è, in fin dei conti, uno stato democratico benevolo, che cerca la pace con i suoi vicini, e che garantisce l’uguaglianza a tutti i suoi cittadini.
Coloro che criticano Israele presumono che, se qualcosa è andato storto con la sua democrazia, è stato a causa della guerra del 1967. Secondo questa opinione, la guerra avrebbe corrotto una società onesta e laboriosa, offrendole facili guadagni nei territori occupati, permettendo a gruppi messianici di introdursi nella politica israeliana, e soprattutto rendendo Israele una forza occupante e oppressiva nei nuovi territori.
Il mito che uno stato democratico di Israele avrebbe avuto dei problemi nel 1967 pur rimanendo una democrazia, è stato tramandato anche da alcuni illustri studiosi palestinesi e pro-palestinesi – ma non ha fondamenti storici.
Israele prima del 1967 non era una democrazia
Prima del 1967, Israele non avrebbe assolutamente potuto essere descritto come una democrazia. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, lo stato sottoponeva un quinto della sua cittadinanza ad un regime militare basato sulle draconiane norme di emergenza del Mandato Britannico che negavano ai Palestinesi qualunque diritto fondamentale, umano e civile.
I governatori militari locali decidevano in toto della vita dei cittadini: potevano ideare leggi speciali per loro, distruggere le loro case ed i loro mezzi di sostentamento, ed imprigionarli quando volevano. Solo alla fine degli anni Cinquanta emerse una forte opposizione ebraica contro questi abusi, che infine allentò la pressione sui cittadini palestinesi.
Per i Palestinesi che hanno vissuto nell’Israele dell’anteguerra e per quelli che hanno vissuto nella Cisgiordania e nella Striscia di Gaza del dopo-1967, questo regime ha permesso persino al soldato di grado più basso nell’esercito israeliano di decidere della loro vita, e di rovinarla. Erano del tutto indifesi se un certo soldato, o la sua unità o il suo comandante, decidevano di demolire la loro casa, o di trattenerli per ore ad un posto di blocco, o di incarcerarli senza un processo. Non c’era nulla che potessero fare.
Dal 1948 ad oggi c’è sempre stato qualche gruppo di Palestinesi che ha vissuto queste esperienze.
Il primo gruppo a soffrire sotto questo giogo fu la minoranza palestinese all’interno di Israele. Tutto cominciò nei primi due anni dalla nascita dello Stato, durante i quali vennero costretti a vivere all’interno di ghetti, come la comunità palestinese di Haifa che viveva sul monte Carmel, oppure furono espulsi dalle città in cui avevano vissuto per decenni, come avvenne a Safad. Nel caso di Isdud, l’intera popolazione fu cacciata nella Striscia di Gaza.
Nelle campagne la situazione era persino peggiore. I villaggi palestinesi situati su terreni fertili facevano gola ai vari movimenti Kibbutz. Compresi i Kibbutzim socialisti Hashomer Ha-Zair, malgrado il loro presunto impegno di solidarietà con entrambi i popoli.
Quando i combattimenti del 1948 erano cessati da un pezzo, gli abitanti dei villaggi di Ghabsiyyeh, Iqrit, Birim, Qaidta, Zaytun, e molti altri, furono indotti con l’inganno a lasciare per un periodo di due settimane le loro abitazioni, di cui l’esercito pretendeva di aver bisogno per esercitazioni, solo per scoprire al ritorno che i loro villaggi erano stati rasi al suolo oppure erano stati concessi a qualcun altro.
Un esempio di questa condizione di terrore militare è il massacro di Kafr Qasim, nell’ottobre del 1956, quando, alla vigilia dell’azione nel Sinai, quarantanove cittadini palestinesi furono uccisi dall’esercito israeliano. Le autorità sostenevano che erano rientrati tardi dal lavoro nei campi, mentre un coprifuoco era stato imposto sul villaggio. Ma questa non era la vera ragione.
È stato dimostrato successivamente che Israele aveva preso in seria considerazione l’espulsione dei Palestinesi dall’intera area chiamata Wadi Ara e dal Triangolo nel quale era situato il villaggio. Queste due regioni – la prima una valle che collegava Afula ad est con Hadera sulla costa del Mediterraneo; la seconda che estendeva l’entroterra orientale di Gerusalemme – erano state annesse ad Israele nel quadro dell’armistizio del 1949 con la Giordania.
Come abbiamo visto, aumenti di territorio erano sempre ben accolti da Israele, mentre non lo era l’aumento della popolazione palestinese. Quindi, ad ogni occasione di espansione dello stato di Israele, si cercava in ogni modo di limitare la popolazione palestinese nelle nuove aree annesse.
Operazione “Hafarfert” (talpa) era il nome in codice di una serie di proposte per l’espulsione di Palestinesi nel momento in cui era scoppiata una nuova guerra con il mondo arabo. Molti studiosi oggi credono che il massacro del 1956 sia stato un esperimento per vedere se fosse possibile cacciar via la gente della zona con l’intimidazione.
Gli esecutori della strage furono processati grazie alla diligenza ed alla tenacia di due membri della Knesset: Tawaq Tubi del Partito Comunista e Latif Dori del Partito della Sinistra Sionista Mapam. Comunque, i comandanti responsabili nella zona, e l’unità stessa che commise il crimine, se la cavarono con poco, pagando solo piccole multe. Questa fu un’ulteriore prova di come l’esercito potesse farla franca commettendo omicidi nei territori occupati.
La ferocia sistematica non si palesa solo in eventi importanti come una strage. Le atrocità peggiori possono riscontrarsi nella presenza quotidiana, ordinaria del regime.
Eppure i Palestinesi in Israele non parlano molto del periodo pre-1967, e i documenti di quel periodo non ne mostrano un quadro completo. È sorprendente come sia nella poesia che troviamo un’indicazione di come fosse la vita sotto un governo militare.
Natan Alterman era uno dei poeti più famosi ed importanti della sua generazione. Teneva una rubrica settimanale, chiamata “La Settima Colonna”, in cui commentava gli avvenimenti dei quali aveva letto o sentito. A volte ometteva dettagli su date o persino luoghi degli avvenimenti, ma forniva ai lettori informazioni sufficienti per capire a cosa si riferisse. Spesso esprimeva i propri attacchi in forma poetica:
La notizia è comparsa brevemente per due giorni, poi è scomparsa. E nessuno sembra preoccuparsene, nessuno sembra saperne niente. Nel lontano villaggio di Um al-Fahem, dei bambini – dovrei dire dei cittadini dello stato – giocavano nel fango. E uno di loro sembrò sospetto a uno dei nostri valorosi soldati che gli urlò: Stop!
Un ordine è un ordine.
Un ordine è un ordine, ma lo sciocco ragazzino non si fermò. Scappò via.
Così il nostro valoroso soldato sparò, naturalmente. E colpì il ragazzo e lo uccise.
E nessuno ne ha parlato.
Una volta scrisse una poesia su due cittadini palestinesi che erano stati uccisi in Wadi Ara. Un’altra volta raccontò la storia di una donna palestinese molto malata che era stata cacciata, con i suoi due bimbi di tre e sei anni, senza spiegazione, e spinta al di là del Giordano. Quando provò a rientrare, lei ed i suoi figli furono arrestati ed imprigionati a Nazareth.
Alterman sperava che la sua poesia sulla madre avrebbe scosso cuori e menti, o che almeno avrebbe ottenuto qualche risposta ufficiale. Invece, la settimana successiva scrisse:
E questo scrittore si era immaginato erroneamente
che la storia sarebbe stata negata o chiarita. Ma niente, non una parola.
Ci sono altre prove che Israele non era una democrazia prima del 1967. Lo stato perseguiva una politica di spara-per-uccidere verso gli sfollati che provavano a rientrare in possesso della propria terra, dei raccolti, del bestiame, ed inscenò una guerra coloniale per far cadere il regime di Nasser in Egitto. Anche le forze di sicurezza avevano il grilletto facile, uccidendo più di cinquanta cittadini palestinesi durante il periodo tra il 1948 ed il 1967.
L’assoggettamento delle minoranze in Israele non è democratico
La cartina al tornasole di ogni democrazia è il livello di tolleranza verso le minoranze che vivono al suo interno. Da questo punto di vista, Israele non è affatto all’altezza di una vera democrazia.
Ad esempio, dopo le nuove acquisizioni territoriali, diverse leggi vennero approvate per assicurare alla maggioranza una posizione dominante: le leggi sulla cittadinanza, le leggi sulla proprietà terriera e, la più importante di tutte, la legge sul ritorno.
Quest’ultima garantisce cittadinanza automatica a qualunque Ebreo del mondo, dovunque sia nato o nata. Questa legge in particolare è palesemente antidemocratica, in quanto si accompagna ad un totale rifiuto del diritto palestinese al ritorno – riconosciuto a livello internazionale dalla Risoluzione 194 del 1948 dell’Assemblea Generale dell’ONU. Questo rifiuto non permette ai cittadini palestinesi di Israele di ricongiungersi con i loro più stretti familiari o con quelli cacciati nel 1948.
Negare ad un popolo il diritto al ritorno nella propria terra, offrendo allo stesso tempo questo diritto ad altra gente che non ha alcun legame con il territorio, è un modello di pratica non democratica.
Si è poi aggiunto un ulteriore livello di negazione dei diritti del popolo palestinese. Quasi tutte le discriminazioni ai danni dei cittadini palestinesi di Israele sono giustificate dal fatto che non fanno il servizio militare. Il nesso tra diritti democratici e doveri militari si comprende meglio ripercorrendo gli anni di formazione dello stato, quando i decisori della politica israeliana cercavano di capire come avrebbero potuto trattare un quinto della popolazione.
Il loro assunto era che i cittadini palestinesi non desideravano comunque fare parte dell’esercito, e che il presunto rifiuto, a sua volta, giustificava una politica discriminatoria nei loro confronti. Questa ipotesi fu messa alla prova nel 1954, quando il ministro della difesa israeliano decise di chiamare a servire nell’esercito i cittadini palestinesi idonei al reclutamento. I servizi segreti assicurarono al governo che ci sarebbe stata una diffusa renitenza alla leva.
Con loro grande sorpresa, tutti i richiamati si presentarono all’ufficio di reclutamento, con la benedizione del Partito Comunista, a quel tempo la forza politica più potente ed importante del paese. I servizi segreti spiegarono in seguito che la ragione principale era stata la noia degli adolescenti di vivere in campagna e il loro desiderio di azione e di avventura.
Malgrado questo episodio, il ministro della difesa continuò a spacciare l’idea di una comunità palestinese riluttante a prestare servizio nell’esercito.
Inevitabilmente, con il passare del tempo, i Palestinesi si sono effettivamente ribellati all’esercito israeliano, che era diventato il loro perenne oppressore, ma il governo ha sfruttato questo elemento come un pretesto per la discriminazione, ciò che getta un dubbio enorme sulla pretesa dello Stato di essere una democrazia.
Se sei un cittadino palestinese e non hai fatto il servizio militare, il tuo diritto all’assistenza governativa in quanto lavoratore, studente, genitore, o membro di una coppia, è fortemente ridotto. Ciò si riflette soprattutto sull’accesso alla casa e all’occupazione, visto che il 70% di tutte le industrie israeliane sono considerate a rischio sicurezza (security-sensitive) e quindi precluse a questo tipo di cittadini come posti in cui cercare lavoro.
L’assunto implicito del Ministero della Difesa è che ai Palestinesi non solo non piace fare il servizio militare, ma che essi costituiscono un potenziale nemico interno di cui non ci si può fidare. Il punto debole di questo ragionamento è che in tutte le maggiori guerre tra Israele e il mondo arabo, la minoranza palestinese non si è comportata come ci si poteva attendere, perché non ha formato una quinta colonna, né si è rivoltata contro il regime.
Questo fatto, però, non ha aiutato i Palestinesi, che sono visti ancora oggi come un problema “demografico” da risolvere. L’unica consolazione è che, ad oggi, la maggior parte dei politici israeliani non crede che il modo di risolvere “il problema” sia quello di trasferire o di espellere i Palestinesi (almeno non in tempo di pace).
La politica israeliana della terra non è democratica.
La pretesa di essere una democrazia appare discutibile anche quando si considera la politica dei fondi coinvolti nella questione della terra. Fin dal 1948, le assemblee locali e le municipalità palestinesi hanno ricevuto fondi molto inferiori a quelli percepiti dalla controparte israeliana. La scarsità di terra disponibile, assieme alla scarsità di opportunità lavorative, ha creato una realtà socioeconomica abnorme.
Per esempio, la più ricca comunità palestinese, il villaggio di Me’ilya nell’Alta Galilea, sta peggio del più povero insediamento cittadino israeliano del Negev. Nel 2011, il Jerusalem Post ha riportato che, “tra il 1997 e il 2009, il reddito medio israeliano era tra il 40 % e il 60 % più alto del reddito medio arabo.”
Oggi più del 90 % della terra è in mano al Jewish National Fund (JNF). Ai proprietari terrieri non è permesso condurre transazioni con cittadini non-ebrei, e la terra demaniale è al servizio prioritario di progetti nazionali: ciò significa che, mentre vengono costruiti nuovi insediamenti ebraici, non c’è praticamente nessun nuovo insediamento palestinese. Così, la più grande città palestinese, Nazareth, nonostante il fatto che dal 1948 la sua popolazione sia triplicata, non si è espansa di un kilometro quadrato, mentre la città-insediamento costruita sopra, Upper Nazareth, ha triplicato la sua superficie, su terra che è stata espropriata a proprietari palestinesi.
Altri esempi di questa politica si possono riscontrare nei villaggi palestinesi sparsi per la Galilea: dal 1948 ad oggi stati ridotti in superficie del 40% e talvolta persino del 60 %, mentre nuovi insediamenti ebraici sono stati costruiti sulle terre espropriate.
In altre aree ciò ha dato inizio a massicci tentativi di “giudeizzazione.” Dopo il 1967, il governo israeliano ha cominciato a preoccuparsi della mancanza di ebrei che vivessero nel nord e nel sud dello Stato e ha pianificato di incrementarne il numero. Per realizzare un simile cambiamento demografico era necessario confiscare della terra palestinese da destinare alla costruzione di insediamenti ebraici.
La cosa peggiore è stata l’esclusione di cittadini palestinesi da questi insediamenti. Questa sfacciata violazione del diritto di un cittadino a risiedere dove vuole continua fino ad oggi, e tutti gli sforzi delle ONG israeliane per i diritti umani per contrastare tale apartheid si sono rivelate fino ad ora totalmente fallimentari.
La Suprema Corte Israeliana è stata in grado di mettere in discussione la legalità di questo procedimento solo in alcuni singoli casi, ma non ha messo in discussione il principio in sé. Immaginate se in Gran Bretagna o negli Stati Uniti, ai cittadini ebrei, o anche cattolici, fosse proibito per legge di vivere in certi villaggi, quartieri o, magari, intere città. Come si può conciliare una situazione del genere con il concetto di democrazia?
L’occupazione non è democratica.
Quindi, visto l’atteggiamento tenuto verso due gruppi palestinesi –i rifugiati e le comunità palestinesi in Israele– non si può pensare in alcun modo che lo stato ebraico sia una democrazia.
Ma la sfida più ovvia a quest’assunto è l’atteggiamento spietato nei confronti di un terzo gruppo di Palestinesi: tutti quelli che, dal 1967, vivono sotto il controllo diretto o indiretto di Israele, a Gerusalemme Est, in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. Dalle infrastrutture legali poste in essere allo scoppio della guerra, al potere assoluto, mai messo in discussione, dell’esercito all’interno della Cisgiordania e fuori dalla Striscia di Gaza, alla quotidiana umiliazione di milioni di palestinesi; l’unica democrazia del Medioriente si comporta come una dittatura della peggior risma.
La principale risposta israeliana, accademica e non, a quest’ultima accusa, è che tutte queste misure sono temporanee—cambieranno se i Palestinesi, dovunque essi si trovino, si comporteranno “meglio”. Ma se uno facesse delle ricerche, per non dire vivesse nei Territori Occupati, si renderebbe conto di quanto ridicole siano queste argomentazioni.
I legislatori israeliani, come abbiamo visto, sono determinati a mantenere in piedi l’occupazione, fino a che lo stato ebraico continua a rimanere intatto. E’ parte di ciò che il sistema politico israeliano considera come lo status quo, che è sempre migliore di qualsiasi cambiamento. Israele controllerà la maggior parte della Palestina e, poiché questa conterrà sempre un numero molto considerevole di palestinesi, potrà farlo solo con mezzi non democratici.
Inoltre, nonostante sia evidente il contrario, lo stato israeliano sostiene che la sua occupazione sia di tipo “illuminato”. Il mito qui è che Israele sia arrivato con le migliori intenzioni di condurre un’occupazione benevola, ma che sia stato costretto ad adottare soluzioni più dure a causa della violenza palestinese.
Nel 1967, il governo ritenne la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, componenti integranti di “Eretz Israel”– la Terra di Israele– e questo atteggiamento continua invariato da allora. Se considerate il dibattito interno ai partiti israeliani di destra e di sinistra su questo nodo cruciale, vi renderete conto che il loro disaccordo riguarda il modo in cui raggiungere tale fine, non la sua validità.
Tra il pubblico più ampio, c’è stato, in effetti, un genuino confronto tra quelli che potremmo chiamare i “salvatori” e i “custodi”. I “salvatori” ritenevano che Israele avesse recuperato il cuore antico della sua terra e che non avrebbe potuto sopravvivere in futuro senza di esso. Al contrario, i “custodi” ritenevano che i territori avrebbero dovuto essere scambiati con la pace: pace con la Giordania–nel caso della West Bank– e pace con l’Egitto, nel caso della Striscia di Gaza. In ogni caso questo dibattito pubblico ebbe scarso effetto sul modo in cui i più incisivi legislatori cercarono di individuare strategie per governare i Territori.
La parte peggiore di questa “occupazione illuminata” fu costituita dai metodi per il controllo dei Territori. All’inizio l’intera zona era stata divisa tra spazi “Arabi” e spazi potenzialmente “Ebraici”. Le aree densamente abitate dai Palestinesi divennero autonome, gestite da collaboratori locali sotto un regime militare. Questo regime fu rimpiazzato da una amministrazione civile solo nel 1981.
Le altre aree, gli spazi “ebraici”, furono colonizzati dagli insediamenti e dalle basi militari. Questa politica aveva l’intento di lasciare la popolazione, sia in Cisgiordania che a Gaza, in spazi chiusi (enclaves) non collegati tra loro, privi di aree verdi e senza alcuna possibilità di espansione urbana.
Le cose non fecero che peggiorare quando, subito dopo l’occupazione, Gush Emunim cominciò a costruire insediamenti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, rivendicando il diritto di seguire una mappa Biblica di colonizzazione piuttosto che quella del governo. Man mano che gli israeliani penetravano nelle aree palestinesi densamente popolate, lo spazio destinato ai locali si riduceva ulteriormente.
Ciò di cui ogni progetto di colonizzazione ha bisogno in primis è la terra – nei Territori Occupati questo obiettivo è stato raggiunto solo attraverso una massiccia espropriazione, allontanando la gente dal luogo in cui era vissuta per generazioni e confinandola in enclaves, le cui situazioni ambientali erano difficili da sostenere.
Quando si sorvola la Cisgiordania si può vedere con molta chiarezza il risultato cartografico di questa politica: cinture di insediamenti che dividono la terra e ritagliano– per le comunità palestinesi–spazi piccoli, isolati e scollegati. Le cinture di giudeizzazione separano villaggio da villaggio, i villaggi dalle città e, talvolta, tagliano in due un singolo villaggio.
Questo è ciò che gli accademici chiamano una “geografia del disastro”, a maggior ragione da quando tali politiche si sono rivelate un disastro anche ecologico, che prosciuga le sorgenti e rovina alcune delle parti più belle del paesaggio palestinese.
Inoltre, gli insediamenti sono diventati focolai in cui l’estremismo ebraico è cresciuto in modo incontrollabile, e le vittime principali ne sono i palestinesi. Per esempio, l’insediamento di Efrat ha rovinato il sito, patrimonio dell’umanità, della Valle di Wallayah, presso Betlemme, e il villaggio di Jafne– vicino a Ramallah– che era famoso per i suoi canali d’acqua sorgiva, ha perso la sua specificità come attrazione turistica. Questi non sono che due piccoli esempi: se ne potrebbero fare a centinaia.
Distruggere le case dei Palestinesi non è democratico
La demolizione di case non è una novità in Palestina. Come è successo con molti dei più barbari metodi di punizione collettiva usati da Israele dopo il 1948, le demolizioni furono escogitate e usate dal governo del Mandato Britannico durante la Grande Rivolta Araba del 1936-39.
Quella fu la prima rivolta palestinese contro la politica filo-sionista del Mandato Britannico, e ci vollero tre anni prima che l’esercito britannico riuscisse a domarla. Nel frattempo, i Britannici distrussero circa duemila case nel corso delle varie punizioni collettive inflitte alla popolazione locale.
Israele cominciò a demolire case praticamente dal primo giorno dopo l’occupazione militare della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. L’esercito ha distrutto centinaia di case ogni anno, in risposta a determinate azioni compiute dai singoli componenti della famiglia.
Si trattasse di piccole infrazioni alle leggi militari o della partecipazione ad atti violenti contro l’occupazione, gli Israeliani mandavano subito i bulldozer per spazzar via non solo una costruzione materiale, ma anche qualunque centro di vitalità e di presenza. Anche nell’area della Gerusalemme metropolitana (così come all’interno di Israele) la demolizione veniva usata per punire l’ampliamento abusivo di una casa già costruita o il mancato pagamento di bollette.
Un’altra forma di punizione collettiva che è comparsa di nuovo nel repertorio israeliano consiste nel blocco delle case. Immaginate che tutte le porte e le finestre della vostra casa siano bloccate con cemento, calce e pietre, in modo che non possiate rientrarci o recuperare qualcosa che non avete fatto in tempo a portar via. Ho cercato a lungo nei miei libri di storia, ma non ho trovato altri esempi di una così brutale misura in nessun’altra parte del mondo.
Schiacciare la resistenza dei Palestinesi non è democratico
Inoltre, grazie a questa “occupazione illuminata,” i coloni hanno potuto formare delle bande di vigilantes che molestano la gente e ne distruggono le proprietà. Queste bande hanno cambiato la loro tattica nel corso degli anni.
Durante gli anni 1980, usavano veri e propri metodi terroristici: dal ferimento di leader palestinesi (uno dei quali perse le gambe durante un attacco), al piano per far saltare le moschee sul Monte del Tempio a Gerusalemme.
Nel nuovo millennio, si sono dedicati a molestare quotidianamente i Palestinesi: sradicando i loro alberi, distruggendo i loro raccolti, e sparando a caso sulle loro case e le loro auto. Dal 2000, sono stati segnalati almeno cento attacchi al mese di questo tipo in alcune zone come ad Hebron, dove i cinquecento coloni, con la tacita collaborazione dell’esercito israeliano, hanno molestato i residenti delle comunità vicine in modi ancora più brutali.
Fin dall’inizio dell’occupazione, quindi, ai Palestinesi sono rimaste due possibilità: o accettare il fatto di essere incarcerati continuativamente in una mega-prigione per tempi lunghissimi, o sfidare la potenza del più forte esercito del Medio Oriente. Quando i Palestinesi banno resistito –come hanno fatto nel 1987, 2000, 2006, 2012, 2014 e 2016–, sono stati trattati come fossero soldati e unità di un esercito convenzionale. E così, villaggi e città sono stati bombardati come se fossero basi militari e la popolazione civile è stata colpita come se fosse un esercito sul campo di battaglia.
Oggi ormai sappiamo sin troppo bene cosa significa vivere sotto occupazione, prima e dopo Oslo, perché possiamo prendere sul serio l’affermazione che meno resistenza vuol dire meno oppressione. Gli arresti senza processo, che abbiamo visto così spesso nel corso degli anni, la demolizione di migliaia di case, l’uccisione o il ferimento di innocenti, il prosciugamento delle sorgenti d’acqua, tutto ciò sta a testimoniare che siamo di fronte a uno dei più brutali regimi dei nostri tempi.
Amnesty International documenta ogni anno in modo esauriente la natura dell’occupazione. Questo è ciò che scrive nel suo Rapporto 2015:
In Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, le forze israeliane hanno commesso uccisioni illegali di civili palestinesi, minori compresi, ed hanno incarcerato migliaia di Palestinesi che protestavano o comunque si opponevano contro la permanente occupazione militare di Israele, trattenendone centinaia in detenzione amministrativa. Torture ed altri maltrattamenti hanno continuato a imperversare e sono stati commessi impunemente.
Le autorità hanno continuato a promuovere insediamenti illegali in Cisgiordania, ed hanno limitato drasticamente la libertà di movimento dei Palestinesi, con un ulteriore inasprimento di tali limitazioni nel corso di un aumento di violenza a partire da metà ottobre, quando si son verificati attacchi palestinesi a civili Israeliani seguìti da esecuzioni apparentemente extragiudiziali da parte delle forze israeliane. Coloni israeliani in Cisgiordania hanno attaccato i Palestinesi e le loro proprietà con sostanziale impunità. La Striscia di Gaza è rimasta sotto il blocco militare israeliano che rappresenta una punizione collettiva sugli abitanti. Le autorità hanno continuato a demolire case palestinesi in Cisgiordania e in Israele, soprattutto nei villaggi beduini della regione del Negev, trasferendo forzatamente i residenti.
Vediamo le cose punto per punto. Innanzitutto gli assassinii (quelli che il Rapporto di Amnesty chiama “uccisioni illegali”): circa 15mila Palestinesi sono stati uccisi “illegalmente” da Israele dal 1967. Di questi, duemila erano minori.
Imprigionare Palestinesi senza processo non è democratico
Un’altra caratteristica della “occupazione illuminata” sono le carcerazioni senza processo. Nella Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, un Palestinese su cinque ha fatto questa esperienza.
È interessante confrontare questa pratica israeliana con procedure americane simili del passato e del presente, perché alcuni critici del movimento BDS affermano che le pratiche USA sono di gran lunga peggiori. In realtà, il peggior esempio americano è stato l’imprigionamento senza processo di 100mila cittadini giapponesi durante la seconda guerra mondiale, 30mila dei quali detenuti poi per la cosiddetta “guerra al terrore.”
Nessuno di questi numeri si avvicina al numero dei Palestinesi che hanno subìto questo trattamento, compresi i bambini, i vecchi e i detenuti per lunghi periodi.
Subire un arresto senza processo è un’esperienza traumatica. Non sapere di cosa sei accusato, non aver contatti con un avvocato e quasi nessun contatto con i familiari sono solo alcune delle preoccupazioni che tormentano il prigioniero. Cosa ancor più brutale, molti di questi arresti vengono usati come uno strumento per spingere le persone a diventare collaboratori. Diffondere pettegolezzi o mortificare le persone per il loro vero o presunto orientamento sessuale, sono altri metodi usati spesso per spingere alla complicità.
Quanto alla tortura, l’affidabile sito web Middle East Monitor ha pubblicato uno sconvolgente articolo in cui si descrivono i duecento metodi usati dagli Israeliani per torturare i Palestinesi. L’elenco si basa su un rapporto dell’ONU e su un rapporto dell’organizzazione israeliana B’Tselem per i diritti umani. Tra i vari metodi ci sono le percosse, oppure incatenare per ore i prigionieri a porte o a sedie, rovesciar loro addosso acqua calda o fredda, divaricare le dita o torcere i testicoli.
Israele non è una democrazia
Quello che dobbiamo contestare, quindi, non è solo la pretesa di Israele di portare avanti un’occupazione illuminata, ma anche la sua pretesa di essere una democrazia. Il comportamento che tiene verso milioni di persone sotto il suo dominio smentisce questo imbroglio politico.
Ciononostante, anche se larga parte della società civile nel mondo nega a Israele la sua pretesa di democrazia, i leader politici, per una serie di ragioni, lo trattano ancora come un membro dell’esclusivo club degli stati democratici. In un certo senso, il successo del movimento BDS riflette la frustrazione di molte società di fronte alle politiche dei loro governi verso Israele.
Per la maggior parte degli Israeliani, queste critiche sono, nel migliore dei casi, irrilevanti oppure sono addirittura calunniose. Lo stato di Israele resta aggrappato all’idea di essere un occupante benevolo. Chi è favorevole alla tesi della “occupazione benevola,” sostiene che, rispetto al cittadino ebreo medio in Israele, i Palestinesi stanno molto meglio sotto occupazione e non hanno alcuna ragione di opporvisi, tanto meno se lo fanno con la forza. E se uno è un sostenitore acritico di Israele all’estero, finisce per accettare anche lui queste affermazioni.
Ci sono, tuttavia, settori della società israeliana che riconoscono la validità di alcune delle affermazioni fatte qui. Negli anni 1990, seppure con vari livelli di convinzione, un numero significativo di accademici, giornalisti e artisti ebrei hanno espresso dei dubbi sulla definizione di Israele come una democrazia.
Ci vuole una certa dose di coraggio per contestare i miti fondativi della propria società e del proprio stato. È per questo che alcuni dei contestatori hanno poi fatto marcia indietro rispetto alle loro coraggiose posizioni iniziali e son tornati a seguire pedissequamente la linea generale.
Tuttavia, nell’ultimo decennio del secolo scorso, [questi intellettuali] hanno per un certo tempo prodotto degli studi che mettevano in dubbio l’assunto di un Israele democratico. Descrivevano anzi un Israele che apparteneva a un’altra comunità: quella delle nazioni non-democratiche. Uno di loro, il geografo Oren Yiftachel della Ben Gurion University, ha definito Israele come una etnocrazia, cioè un regime che governa uno stato multietnico esercitando una preferenza legale e formale per un gruppo etnico al di sopra degli altri. Altri sono andati anche oltre, etichettando Israele come uno stato di apartheid o uno stato di insediamento coloniale.
In poche parole, quali che fossero le descrizioni offerte da questi studiosi, la “democrazia” non era una di queste.
Ilan Pappe
Ilan Pappe è uno storico israeliano e un attivista socialista. È professore al College of Social Sciences and International Studies dell’Università di Exeter, direttore dell’European Centre for Palestine Studies di quella università, e condirettore dell’Exeter Centre for Ethno-Political Studies. È autore del recente libro Ten Miths About Israel.
Questo articolo è stato inizialmente pubblicato da “Jacobin”. Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non riflettono necessariamente quelle della Information Clearing House.
http://www.informationclearinghouse.info/49617.htm
Traduzione di Rosaria Brescia e Anna Maria Torriglia

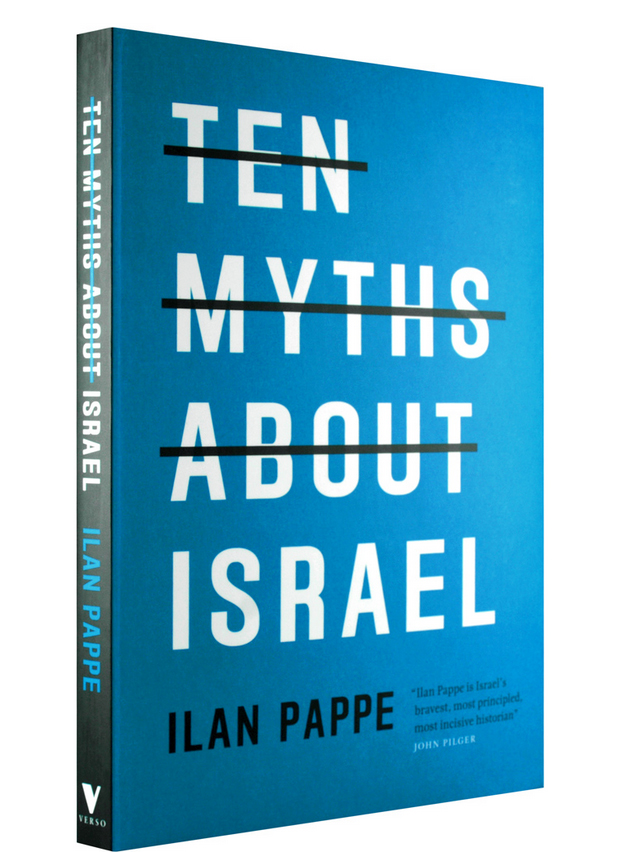



0 commenti