Herzl sostenne il brutale sultano ottomano contro gli Armeni, credendo che questo inducesse il sultano a vendere la Palestina agli ebrei.
Haaretz 1 maggio 2015
di Rachel Elboim-Dror
Professoressa emerita di storia e cultura alla Hebrew University
La questione armena ha interessato il movimento sionista sin da quando i turchi fecero un massacro di armeni alla metà degli anni 1890 – prima ancora del Primo Congresso Sionista. La strategia di Herzl si basava su un progetto di scambio: gli ebrei avrebbero pagato l’enorme debito dell’Impero Ottomano, e in cambio avrebbero ottenuto la Palestina e la possibilità di stabilirci uno stato ebraico, col consenso delle maggiori potenze. Herzl aveva cercato in ogni modo di persuadere il sultano Abdul Hamid II ad accettare, ma senza successo.
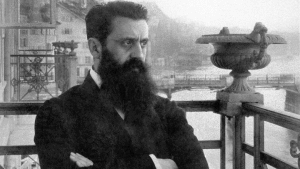 Theodor Herzl a Basilea, per il primo Congresso Sionista. Central Zionist Archive/Courtesy Simon Wiesenthal Center
Theodor Herzl a Basilea, per il primo Congresso Sionista. Central Zionist Archive/Courtesy Simon Wiesenthal Center
“Invece di offrire soldi al Sultano,” gli disse il suo agente diplomatico Philip Michael Nevlinski (che fece da consulente anche al sultano), “offrigli appoggio politico sulla questione armena e vedrai che accetterà la tua proposta, almeno in parte.” I paesi cristiani d’Europa avevano criticato l’assassinio dei cristiani armeni ad opera dei musulmani, comitati a sostegno degli armeni erano stati costituiti in vari paesi e l’Europa offriva anche rifugio ai leader della rivolta armena. Questa situazione rendeva assai difficile per la Turchia ottenere prestiti dalle banche europee.
Herzl seguì con entusiasmo il consiglio. Pensava fosse giusto tentare ogni strada per affrettare la nascita di uno stato ebraico. Acconsentì quindi a servire come strumento del Sultano e cercò di convincere i leader della rivolta armena che se si fossereo arresi al Sultano, questi avrebbe accolto alcune delle loro richieste. Herzl cercò anche di mostrare all’Occidente che la Turchia era anzi molto umana, che non aveva altra scelta che gestire in quel modo la rivolta armena, e che voleva la fine del conflitto e l’intesa politica. Dopo molti tentativi, il 17 maggio 1901 ebbe anche un incontro con il Sultano.
Il Sultano sperava che Herzl, giornalista famoso, sarebbe stato capace di mutare l’immagine negativa dell’Impero Ottomano. Quindi Herzl lanciò un’intensa campagna per soddisfare il desiderio del Sultano, presentando se stesso come un mediatore per la pace. Stabilì contatti ed ebbe incontri segreti con i ribelli armeni, nel tentativo di convincerli a cessare ogni violenza, ma i ribelli non si convinsero della sua sincerità e non credettero alle promesse del Sultano. Herzl tentò anche energicamente di usare per il suo disegno i canali diplomatici europei, che lui conosceva molto bene.
Come era nel suo carattere, non si consultò con altri leader del movimento sionista, e continuò ad agire in segreto. Tuttavia, occorrendogli un aiuto, scrisse a Max Nordau cercando di cooptarlo al suo progetto. Nordau rispose con un telegramma di una parola: “No”. Nella sua ansia di ottenere dai turchi la concessione della Palestina, Herzl dichiarò pubblicamente – quando l’annuale Congtresso Sionista era già iniziato – che il movimento sionista esprimeva la sua ammirazione e la sua gratitudine per il Sultano, sollevando le proteste di alcuni rappresentanti.
Il principale oppositore di Herzl su questa questione era Bernard Lazare, un intellettuale ebreo francese di sinstra, noto giornalista e critico letterario, che si era distinto nella battaglia contro il processo Dreyfus ed era un sostenitore della causa armena. Era così infuriato contro l’operato di Herzl che si dimise dal Comitato Sionista e abbandonò del tutto il movimento nel 1899. Lazare pubblicò una lettera aperta a Herzl in cui chiedeva: come è possibile che chi pretende di rappresentare un antico popolo la cui storia è scritta col sangue, offra una mano a degli assassini senza che nessun delegato del Congresso Sionista si levi a protestare?
Questo dramma che ha coinvolto Herzl – un leader che ha messo in secondo piano ogni considerazione umanitaria e si è posto al servizio del potere turco in nome dell’ideale di uno stato ebraico – è solo uno dei molti esempi di conflitto tra obiettivi politici e principi morali. Israele si è trovata più volte di fronte a simili tragici dilemmi, come dimostra la sua ormai annosa posizione di non riconoscre ufficialmente il genocidio armeno, così come da altre più recenti decisioni che riflettono la tensione esistente tra valori umanitari e considerazioni di realpolitik.
traduz. di Donato Cioli




0 commenti
Trackback/Pingback