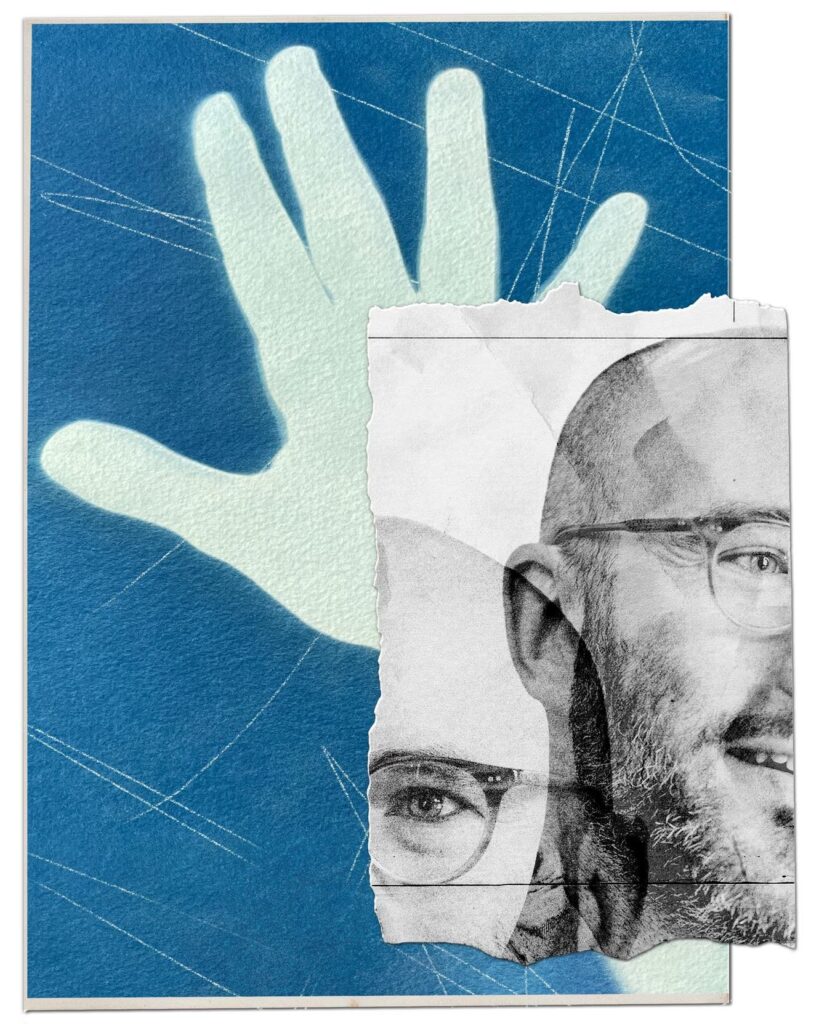di Guy Ben-Aharon,
The Atlantic, 14 luglio 2025.
Troppo israeliano per essere una vittima e troppo resistente per essere un patriota: sono in esilio, anche quando sono a casa mia.
Dal 7 ottobre vivo in un posto strano. Non un luogo fisico, ma una condizione: un limbo tra due mondi che mi dicono entrambi “Non appartieni a questo posto”.
In Israele sono odiato perché mi oppongo a una guerra che molti dicono di non sostenere, ma che continuano a combattere, difendere o giustificare come necessaria. All’estero non sono più il benvenuto tra coloro che dicono che tutti gli israeliani sono colonizzatori.
Sono troppo israeliano per essere una vittima e troppo resistente per essere un patriota. Sono in esilio, anche quando sono a casa mia.
Ho parlato pubblicamente contro questa guerra fin dall’inizio. Come regista teatrale, ho messo in scena spettacoli teatrali troppo politicamente impegnati per essere rappresentati in Israele, nonché la prima in lingua inglese di un’opera teatrale sull’assedio di Gaza. Ho rifiutato di prestare servizio nell’esercito e da anni mi batto contro l’occupazione.
Niente di tutto questo sembra avere importanza. Sono israeliano, e questo è diventato un verdetto.
Durante una cena di Shavuot [ricorrenza ebraica] con la mia famiglia allargata, una parente si è lamentata dei fattorini arabi che consegnano cibo a domicilio. “Questi arabi sanno fare solo due cose con i pacchi”, ha detto. “Rubarli o farli saltare in aria”.
Le ho detto che sembrava una razzista.
Tutta la tavolata è esplosa in un dibattito sulla guerra, a cui tutti dicevano di essere contrari, anche se un membro della famiglia è un medico militare e un altro si sta arruolando. “Cosa ci fai qui?”, mi ha detto il padrone di casa. “Che diritto hai di parlare? Non hai prestato servizio militare”.
Mio padre ha cercato di difendermi: “Mio figlio è un cittadino. È un pacifista. A volte faccio fatica ad accettare le sue opinioni, ma le rispetto. Questa è una democrazia. Ha il diritto di esprimersi”.
“Se fossimo a casa tua”, ha ribattuto il padrone di casa, “me ne andrei. Ma questa è casa mia”.
In altre parole: Vattene.
Il viaggio in auto da Gerusalemme a casa è durato più di un’ora. Nessuno di noi ha parlato: né io, né mia madre, né mio padre. Il silenzio regnava sul sedile posteriore, trattenendo tutto ciò che non sapevamo come dire.
Qualche giorno dopo, uno dei miei familiari mi ha mandato un messaggio dicendomi che, con le opinioni che ho, dovrei rinunciare alla cittadinanza israeliana.
Trovo difficile giudicare questo membro della mia famiglia. Si sente intrappolato in una posizione impossibile: è il padre di un soldato che combatte una guerra che lui stesso non sostiene; è traumatizzato dagli eventi del 7 ottobre. La sua rabbia non è astratta, è personale, autoprotettiva, reale.
Una settimana dopo, sono andato a un concerto a Tel Aviv con mio padre. Un gruppo femminile chiamato Ha’Ivriot, le donne ebraiche, ha eseguito le canzoni con cui sono cresciuto, le canzoni con cui è cresciuto mio padre. Tutto il pubblico ha cantato insieme. Anch’io. E poi, nel bel mezzo di una strofa, ho iniziato a piangere. Cosa ne sarà di questa lingua? Mi sono chiesto. Cosa ne sarà di questa cultura? Siamo riusciti a rovinare tutto.
All’inizio della primavera ho partecipato a una conferenza in Europa per leader culturali di tutto il mondo. Quaranta partecipanti si erano riuniti per immaginare un futuro comune. Sono arrivato pieno di speranza. Sono partito con un senso di vuoto.
Tre partecipanti non mi hanno mai rivolto la parola, non hanno mai incrociato il mio sguardo. La mia opposizione alla guerra, la mia carriera artistica, il mio attivismo: niente di tutto questo sembrava contare. Poi, il penultimo giorno, uno di loro ha parlato durante una sessione pubblica dicendo di sentirsi psicologicamente a disagio durante l’incontro perché, secondo le sue parole, “l’assassino è nella stanza”. Ho capito immediatamente. L’assassino ero io.
Non ho risposto. Cosa avrei potuto dire? Che sono “uno dei buoni”? Non c’è frase che possa ammorbidire la decisione di una persona che ti considera irredimibile. Qualsiasi risposta non farebbe che rafforzare l’accusa.
Qualche giorno dopo sono volato ad Atene per aiutare la mia ragazza, anche lei israeliana, a rifarsi una vita. Aveva lasciato Israele, incapace di convivere con ciò che era diventato il nostro paese. Mi sono unito a lei per un po’, soggiornando nel suo nuovo quartiere, cercando di costruire qualcosa che assomigliasse a una routine.
Un amico greco che gestisce una ONG mi ha invitato a un picnic nel parco. Mi sono seduto su una coperta accanto a un giovane artista del Cairo. Abbiamo parlato di Atene, di arte. Il giovane egiziano mi piaceva. Poi mi ha chiesto dove vivessi.
“Tra Israele e gli Stati Uniti”, ho risposto.
Si è alzato senza dire una parola e se n’è andato.
Più tardi quella stessa sera, un regista teatrale greco mi ha detto: “Mi dispiace, ma sono molto turbato dalla situazione nel tuo paese. Dal tuo genocidio”.
Gli ho detto che anch’io ero molto turbato. Che la mia ragazza aveva lasciato Israele per questo. Che ho fatto sentire la mia voce e mi sono opposto.
Lui ha sbattuto le palpebre. Potevo vedere il meccanismo delle sue supposizioni andare in corto circuito. Sembrava non sapere cosa fare con la tridimensionalità della persona che aveva davanti.
Ogni mattina, mentre portavo a spasso il cane della mia ragazza, cercavo di sentirmi normale. Ma i graffiti erano ovunque. Alcuni chiedevano la libertà per la Palestina, cosa che sostengo con tutto il cuore. Ma altri messaggi mi facevano rabbrividire: “Salva una vita. Uccidi un sionista”. E “Quando un israeliano ti chiede un caffè, servigli un caffè”, accanto alla raffigurazione di una tazza bollente che colpisce un viso. In quegli slogan non c’era spazio per qualcuno come me. Anche i muri avevano deciso.
Capisco la rabbia. Le atrocità a cui assistiamo, trasmesse in diretta streaming, senza sosta, rendono quasi impossibile provare empatia. In un mondo così pieno di sofferenza, la semplificazione può sembrare una forma di sopravvivenza.
Quindi mi chiedo: dove dovrei andare, come pacifista israeliano?
I miei stessi parenti mettono in dubbio che io appartenga a Israele, perché critico le truppe a Gaza per l’uccisione e l’affamamento dei palestinesi. All’estero, un collega di teatro una volta mi ha detto di “tornare da dove sono venuto”, che non appartengo alla terra in cui sono nato, ma alle terre dove i miei antenati hanno affrontato i pogrom e l’Olocausto. Le sfumature non hanno alcun valore in un mondo dipendente dagli assoluti.
Naturalmente, ci sono tragedie ben più gravi della mia. I palestinesi vengono uccisi a Gaza e gli ostaggi israeliani sono ancora in prigionia. Porto ogni giorno il peso di questi orrori. Non sto paragonando la mia sofferenza alla loro. Ma credo che se vogliamo un futuro diverso, abbiamo bisogno di spazio per esprimerci da qualsiasi posizione ci troviamo, anche da quella scomoda di chi sta in mezzo.
Se sia in patria che all’estero si esige fedeltà piuttosto che ricerca, purezza piuttosto che complessità, che spazio rimane a chi difende il diritto sia dei palestinesi che degli israeliani di vivere sulla propria terra?
Quando il dissenso viene zittito come tradimento in un luogo e liquidato come irrimediabile in un altro, chi può immaginare qualcosa di diverso da una guerra perpetua?
Guy Ben-Aharon è un regista teatrale che divide il suo tempo tra gli Stati Uniti e Israele. È anche fondatore e direttore esecutivo di The Jar.
Traduzione a cura di AssopacePalestina
Non sempre AssopacePalestina condivide gli articoli che pubblichiamo, ma pensiamo che opinioni anche diverse possano essere utili per capire.